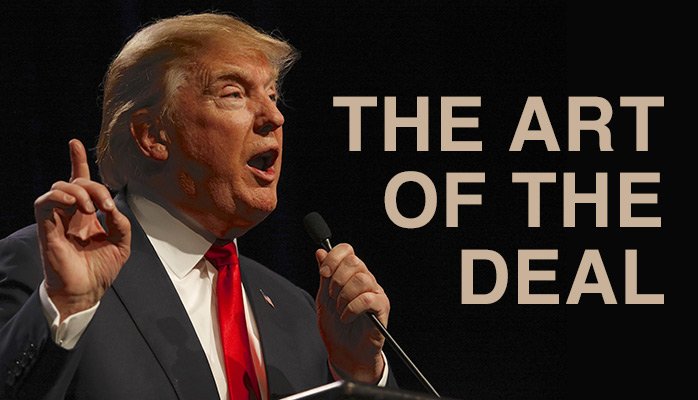Tra realismo e navigazione a vista: Medio Oriente e G7 di Taormina
Il presidente Trump, nel suo primo discorso all’estero, a Riad, in Arabia Saudita, per il summit di fine maggio al King Abdulaziz Center, organizzato dal re Salman, con 55 leader dei Paesi arabi e islamici, come base d’intenti della sua politica estera, ha usato il termine “principio di realismo”. Per una definizione che proprio non va giù a molti, compreso a Paul R. Pillar, accademico (di fama) prima a Princeton e poi a Georgetown, nonché scrittore e con una lunga carriera alle spalle nell’intelligence statunitense.
Fermi tutti
ha detto Pillar. Trump, anche rispetto alle due precedenti amministrazioni statunitensi, che in modi diversi hanno comunque posto una certa importanza ai valori liberali democratici in politica estera, non ha preoccupazioni di sorta rispetto ai diritti umani. Ma questo aspetto, a suo avviso, non può definirsi “realismo”.
In estrema sintesi, i realisti considerano il mondo realisticamente, con un occhio di riguardo al pragmatismo del “così com’è”, piuttosto che avventurarsi in azioni rivoluzionarie ispirate a qualche idealismo ma difficilmente attuabili. Però, ugualmente, Trump risulta agli antipodi di questa filosofia, avendo perseguito un percorso, prima imprenditoriale e poi politico, pieno di menzogne, dove, più della realtà vera e propria, è la sua verità personale che cerca – spesso riuscendoci – di vendere al mondo intero.
Oltre a un rispetto fondamentale per la verità e la realtà, il realismo come approccio alla politica estera si sforza di sfruttare gli interessi delle altre nazioni per avanzare parallelamente gli interessi del proprio paese. E anche in questo caso, con Trump, siamo del tutto fuori strada. Infatti, anche al G7 di Taormina, ha scontentato e irritato tutti, con l’unica posizione contraria nell’ambito della lotta al riscaldamento globale e poi con la linea del protezionismo commerciale del mercato interno dicendo agli storici alleati tedeschi che “sono cattivi, molto cattivi”.
E nemmeno a Riad si è trattato di realismo, definendo l’Iran “il male assoluto” e prendendo una drastica posizione pro sunniti contro gli sciiti (che peraltro nessuno gli aveva chiesto e si aspettava con questi toni). Nella successiva visita in Israele non ha fatto nessun riferimento allo Stato palestinese e agli effetti dell’occupazione israeliana, disattendendo tutte le dichiarazioni della campagna elettorale pur di assecondare la volontà dei suoi ospiti. Per giunta, con una palese predisposizione di Trump verso i governi autoritari rispetto a quelli democratici occidentali. Tutto ciò nulla ha a che fare con il realismo, perché queste potenziali intese hanno ben poco di reciprocamente vantaggioso. E secondo Pillar, il comportamento di Trump presidente arriva direttamente dal Trump imprenditore – che lui definisce come un “predatore immobiliare” – quando il suo mondo si divideva tra “vincitori” e “perdenti”, per un dualismo che più lontano dallo spirito realista non si può.
Mentre un vero realista cercherebbe di ribilanciare il rapporto sia con i sunniti che con gli sciiti, per dare stabilità al Medio Oriente con la figura degli Stati Uniti come equilibratore – anche militare – dell’area; un vero realista non trascurerebbe la situazione palestinese; e un vero realista, sempre in quell’area, non si sarebbe mai congratulato con Erdogan per la vittoria al referendum costituzionale dell’aprile 2017, perché comunque siamo di fronte a un autoritarismo che mina la Turchia nelle relazioni internazionali in Medio Oriente e con gli alleati d’Europa.
In conclusione, quello di Trump sembra un “realismo” simile alla navigazione a vista del peggior Berlusconi, nell’attesa che anche The Donald faccia le corna alla Merkel.[sociallocker id=12172].[/sociallocker]
Sempre in base al “realismo” di Trump, il giudizio di Robert E. Hunter – alto diplomatico statunitense di lunghissimo corso – è tagliente.
“Chi, come me, è immerso da decenni nella vita politica di Washington – dice lui – non ha mai visto nulla di simile, compreso il collasso nervoso dei grandi network nazionali, nella demonizzazione di Trump e nella discussione della classe politica americana per l’inadeguatezza di un simile presidente. Dinanzi a questa prospettiva, non doveva essere eletto”
Continua Hunter:
“La nazione è sopravvissuta a molte prove e sopravvivrà anche oggi ma in termini di impatto sulla politica americana e sulla società, siamo a livello del Watergate, con danni collaterali soprattutto in politica estera”
I riferimenti sono soprattutto per il “Russiagate”, ossia le presunte rivelazioni di informazioni segrete da parte di Trump al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ma prima ancora fa polemica il ruolo esercitato da Mosca in diverse fondamentali questioni di sicurezza nazionale americana, come le ingerenze nelle elezioni presidenziali del 2016. Con un aspetto che secondo Hunter è ben chiaro e attribuibile al comportamento di Trump: “peggio di un crimine, è un errore”.
Il Russiagate si basa su fondamenta ben chiare. In primo luogo c’è il desiderio di Trump di adottare un approccio diverso, ma non ancora specificato in quale direzione debba andare, per affrontare lo sfidante russo dopo che i suoi ultimi due predecessori non sono riusciti a limitare l’arroganza di Vladimir Putin. Poi, aspetto non secondario, c’è l’incapacità di Washington di gestire i rapporti con la Russia per la sicurezza occidentale.
Per dinamiche che arrivano da lontano.
Nel 1975, con il Patto di Helsinki, la Russia – allora ancora Unione Sovietica – accettò l’inviolabilità delle frontiere nazionali in Europa. Nel 1994, a Budapest, insieme a USA e Regno Unito, la Russia – ai tempi Federazione russa – firmò un memorandum per il rispetto dell’indipendenza e della sovranità dei confini esistenti dell’Ucraina, con la promessa di non usare armi contro Kiev tranne in caso di autodifesa. Accordi violati da Putin nel 2014 con l’annessione della Crimea e con i conflitti in Ucraina, seguiti da intimidazioni agli alleati della NATO in Europa centrale, al quale si possono aggiungere i cyber-attacchi in mezzo mondo e un ruolo sempre più rilevante – anche a causa della incertezza della politica estera statunitense – nei confronti della guerra civile siriana, riaffermando lo status di grande potenza in Medio Oriente.
La mancanza di rispetto verso la sicurezza interna di altri paesi con intromissioni varie e un palese quanto odioso esercizio di sfere di influenza russa sono parte del DNA di Mosca. D’altro canto, testare seriamente se la Russia avrebbe potuto in qualche modo essere indotta a svolgere un ruolo costruttivo nella sicurezza internazionale – con altri accordi e vantaggi per tutti – non è stato adeguatamente verificato da parte degli USA. Questo perché nelle tre amministrazioni statunitensi che hanno preceduto quella di Trump, la Russia, una volta a terra con il crollo dell’Unione Sovietica, a terra doveva restarci, in una dinamica che però era in netto contrasto con i bisogni fondamentali dell’Occidente.
Eppure nel 1989, il presidente George W. Bush, mise in campo una strategia lungimirante e senza precedenti per un’“Europe whole and free”, comprendendo che la Russia non poteva essere trattata come la Germania nel Trattato di Versailles del 1919 (per un’acredine che poi ha generato la Seconda guerra mondiale). Ma già prima che Putin fosse al potere, Washington ha cambiato la rotta tracciata da Bush Senior, con diversi sgarri, per mano della NATO, nello scacchiere vitale russo, verso i suoi confini in Europa centrale.
Ovviamente la Russia non è scusabile per i suoi comportamenti in Crimea, Ucraina e per le altre pressioni in Europa. Come non lo sono nemmeno le interferenze nella campagna elettorale presidenziale americana, anche se possono essere giustificate dal fatto che gli Stati Uniti, per decenni, sono attivamente intervenuti nella politica e nelle elezioni di decine di paesi in tutto il mondo. Ma il Russiagate che riguarda il presidente Trump, sta privando gli USA della possibilità di ripristinare rapporti costruttivi con la Russia per il bene di interessi comuni, Occidente in genere compreso, per un realismo che servirebbe nelle azioni e non nelle parole.